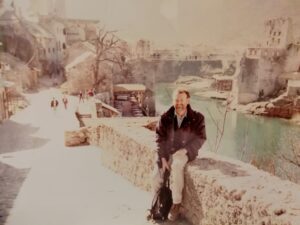E' il momento di abbandonare
gli abiti dello sconforto e della rassegnazione,
per tornare a risplendere di quella luce
che sei chiamata a ricevere da Dio e donare al mondo
Don Mimmo Battaglia,
Arcivescovo di Napoli
18.09.2025 - A chiusura del XXXI Sinodo ha consegnato alla Chiesa di Napoli il testo degli Orientamenti Pastorali. L'icona di Emmaus è la guida del percorso.
ORIENTAMENTI PASTORALI: missione, prossimità, educazione, vocazione, corresponsabilità
Premessa
1. Con grande trepidazione e gioia, cara Chiesa di Napoli, sono lieto di consegnarti queste pagine di bellezza e di speranza che parlano di Te, dei tuoi sogni e delle tue attese, delle tue fatiche e incertezze, delle tue grandi potenzialità e ricchezze. Sono pagine “ispirate”, perché abitate dallo Spirito, e per questo ti chiedo di accoglierle come un dono prezioso, cogliendone il senso più profondo che le abita, che è in fondo la volontà di realizzare il sogno di Dio che tu ti vesta sempre più di Vangelo.
2. Sì, mia amata Chiesa, è il momento di abbandonare gli abiti dello sconforto e della rassegnazione, per tornare a risplendere di quella luce che sei chiamata a ricevere da Dio e donare al mondo. Siano queste pagine quegli «otri nuovi» nei quali lasciar riposare il prezioso vino del messaggio di Cristo (Lc 5, 38), che attraverso di te vuole raggiungere ogni storia, ogni volto, ogni passo degli uomini che popolano questa terra.
3. Questo dono è posto al termine del cammino sinodale che abbiamo vissuto e ne appresenta la sintesi e il frutto. La Provvidenza ha voluto che, proprio in questo tempo, potessimo fermarci, insieme, per ripensare alla nostra missione; ci siamo interrogati su cosa Dio volesse da noi nell’oggi che ci è chiesto di abitare. Il nostro percorso è sostenuto dalla sensibilità della Chiesa universale, che ha scelto di recuperare la sinodalità come suo stile distintivo1 attraverso il Sinodo terminato nell’ottobre del 2024, così come dal cammino sinodale delle Chiese in Italia che ha offerto spunti e piste perché ogni Chiesa locale ragionasse sul suo futuro di speranza.
4. Il Giubileo della Speranza, nel quale siamo innestati, ci incoraggia a diventare pellegrini di speranza e discepoli del Maestro. L’invito che ti rivolgo, mia cara Chiesa di Napoli, è quello di camminare tra queste pagine con un cuore carico di speranza: tutto quello che è scritto e sognato, è possibile! Tutto quello che il nostro camminare insieme è stato capace di immaginare non è soltanto un’utopia intellettuale, ma è una realtà che può essere costruita con le mani e l’impegno di tutti, perché cambi in meglio la nostra storia. Permettimi di raccontarti, mia cara terra, quello che sei e di sognare insieme a te quello che il Signore ti chiama a essere.
5. Terra mia, ti ho chiamata così fin dai passi del primo giorno, non per retorica o compiacenza, ma perché davvero, fin da subito, ho cercato di rendere incarnato
quel matrimonio con te, misticamente significato nel mio servizio episcopale e nella missione ricevuta dall’indimenticabile Papa Francesco. Com’è bello guardarti, Napoli
mia: al buio o durante il giorno, d’estate o d’inverno, dalle terrazze e dai vicoli, tutto di te parla di bellezza, tutto di te mi ha parlato fin da subito di Dio.
6. Scrutare questa terra costringe a farsi innumerevoli domande, a chiedersi infiniti “perché”. Quanti interrogativi in questo tempo trascorso con Te! Quante grida,
quante invocazioni sono giunte alla mia porta! Molte di queste hanno segnato le mie giornate, le mie notti e le mie preghiere.
7. Davanti a questo mare in tempesta in cui spesso Napoli sembra navigare, ciascuno è chiamato a scegliere una strada. C’è chi sceglie la via dell’indifferenza e dell’egoismo, pensando soltanto ai propri privilegi e rinunciando a farsi carico di sofferenze e pesi che non sente come propri. C’è poi la strada di chi fa di ogni angolo di questa città, di ogni volto, di ogni fatica e desiderio, quella terra mia che cantava Pino Daniele, da amare, custodire e coltivare. Ho scelto la seconda strada, perché il Signore in cui credo non avrebbe fatto diversamente.
8. Ho scelto di fare di questa terra la terra mia, e allora l’ho guardata, l’ho ascoltata, ho iniziato a sognare e a camminarci insieme. Facendo memoria grata di ogni incontro, è importante per me dedicare il primo spazio di questo testo a ripercorrere tutte le fatiche, le ferite e le solitudini della terra mia, che sono diventate anche le nostre, mia amata Chiesa partenopea.
9. Le fatiche. Le nostre. Quelle dei tanti poveri dei quali ho cercato di affiancare la storia e che hanno interpellato la mia vita, richiamandola all’essenzialità che consente che tutti abbiano il necessario per vivere. Le incertezze. Quelle dei lavoratori vittime della precarietà, che ho scelto di ascoltare e proteggere davanti all’insensatezza delle prove che sono chiamati a sostenere, tentando anche di cercare soluzioni creative per mostrare la mia volontà di vicinanza e di aiuto. Sono le condizioni dei luoghi dove si respira l’abbandono istituzionale e dove la violenza sembra impedire che il Regno di Dio cresca e si diffonda.
10. Le ferite. Quelle inflitte dalla prepotenza di coloro che pensano di potersi permettere il diritto di stroncare le vite delle sorelle e dei fratelli: femminicidi, omicidi, barbarie di quartiere. Sono le povertà valoriali che governano il mondo dei nostri giovani, collocandoli sulle prime pagine, in cronaca nera, per tragedie assurde e prive di senso, che infangano i valori della vita, dell’amicizia e dell’amore.
11. Le solitudini di chi è in carcere, la cui speranza di risurrezione è costantemente messa alla prova dalla realtà che sembra andare nella direzione della sconfitta
eterna. Sono le emergenze educative, che ostruiscono le possibilità di crescita del nostro territorio. Le fatiche dei sacerdoti che, pur spendendosi con enorme generosità e dedizione, sono costretti spesso a ritmi di vita frenetici a causa della sempre maggiore complessità pastorale e delle numerose responsabilità gestionali. Sono le condizioni delle parrocchie, che camminano con il desiderio di annunciare il Vangelo, ma si scontrano con l’indifferenza e la sordità del mondo contemporaneo.
12. Eccoti, terra mia. Sei qui, davanti a me, come in un sogno che si fa memoria. Ho camminato al tuo fianco, passo dopo passo, su questa via crucis che non è solo
tua, ma anche mia. A volte, sono riuscito a sollevare un frammento del tuo peso, come un Cireneo silenzioso e stanco. Altre volte, mi sono limitato a piangere con te, impotente, asciugando le lacrime che non sapeva parole come le donne del venerdì, piegate dal dolore e nella fede. Fin dall’inizio ho sentito che solo da Lui, da quel volto sfigurato e amante, può nascere la speranza. Solo sapendo che oltre la croce c’è un sepolcro vuoto si trova il coraggio di rialzarsi, di ricominciare. Ed è proprio lì, in quel mistero che sa di luce e ferite, che la strada si trasforma. La via del dolore si fa via lucis. E tu, terra mia, sei soglia di risurrezione. Camminando ancora, lo capiamo: ogni passo può diventare incontro, ogni caduta, resurrezione.
13. Io, Vescovo e Padre, sono il primo a doverci credere. Ma davanti al silenzioso grido delle croci di Napoli, mi sono fatto piccolo. Piccolo e in ascolto. È da lì che è nato il Sinodo: non da un progetto, ma da un’urgenza del cuore. E allora, Chiesa mia, ti ho chiamata. Ti ho chiesto di salire con me sul Calvario di questa terra ferita. E tu ci sei stata. Hai risposto con mani aperte, con passi decisi, con l’anima accesa di fede. Hai ascoltato, hai pianto, hai condiviso ogni ferita che brucia nei vicoli, nei volti, nei giorni di questa città. Ti ho chiesto di non avere paura del dolore, ma di attraversarlo. E tu, come la poesia che ancora ci risuona dentro, hai creduto che «nun è over, nun è semp o’ stess, e tutt’ ’e juorne po’ cagnà». Vorrei trovare le parole per raccontarlo: la bellezza che ci ha sorpresi, la speranza che ha preso corpo, la luce che, piano piano, ha bucato il buio. Questo è stato il nostro Sinodo: un respiro comune, una scommessa d’amore, una sorgente viva da cui oggi ancora sgorga la nostra speranza.
14. Nelle pagine che seguono, non ascolterete soltanto la voce del Vescovo. Sarà la voce corale della Chiesa di Napoli, intera, viva, palpitante. Per questo scegliamo un linguaggio nuovo: non più il singolare dell’io chiuso in sé stesso, ma il plurale del noi che si apre e si dona. Dal riflesso autoreferenziale alla luce condivisa della comunione. Perché la nostra forza nasce dall’essere un solo corpo, un solo spirito (Ef 4,4), un’unica voce che canta nella diversità le note della speranza.
15. Insieme. Insieme, come ci vuole il Maestro. Insieme, come ci ha chiesto per ben cinque volte Papa Leone XIV nella prima Benedizione Urbi et Orbi. Abbiamo camminato così, passo dopo passo, mese dopo mese. Queste pagine sono il frutto maturo di quel cammino condiviso. Abbiamo capito che non c’è altra via: solo nell’unità possiamo annunciare la fraternità, viverla, offrirla al mondo. Chiesa di Napoli, grazie. Grazie per aver accettato la sfida del cammino comune, per aver desiderato quella conversione al noi che il Vangelo ci domanda. Che il noi diventi il tuo respiro. Il tuo stile. La tua profezia.
...