Negazionisti di fatto
Per molto tempo hanno negato i cambiamenti climatici, poi hanno fatto finta di niente, ora governanti e grandi imprese lanciano proclami continuando a fare come prima. Impianti con la neve artificiale, auto elettriche, Ponte sullo Stretto, alta velocità, produzione di armi per le guerre… Il negazionismo di fatto, climatico e ambientale, mentre Po e Adige sono in secca, è sempre più feroce. Abbiamo bisogno di conversione ecologica e di nuove forme di solidarietà per affrontare le crescenti difficoltà di ogni giorno. “Chi (le città e i territori) si sarà attrezzato per tempo per queste cose – scrive Guido Viale – avrà più possibilità di sostenere una vita decente e di accogliere anche le persone costrette a fuggire dal loro Paese reso invivibile forse per sempre….”
Tratta da unsplash.com
Dilaga il negazionismo climatico e ambientale. Quello concreto. Quello effettivo. Finché la disputa si svolgeva all’interno della comunità scientifica, i negazionisti – in Italia guidati prima dal professor Zichichi, “lo scienziato di Andreotti”, poi da Paolo Prodi, il fratello scemo di Romano – sono sempre stati una piccola minoranza in continua diminuzione, ancorché ben foraggiata dall’industria dei fossili. Imperversavano sui media con affermazioni perentorie che avevano poi un vago riflesso nelle rare discussioni sul tema che si svolgevano nei bar e ai giardinetti. Greta Thunberg, con il suo appeal mediatico, ha imposto una svolta ai media (certo, non tutti, provate a leggere Libero…), che da allora hanno cominciato a prendere sul serio l’argomento: mai, o quasi, comunque, in prima pagina o in apertura dei notiziari. E che “il problema” ci sia, e sia serio, ormai non lo nega quasi nessuno.
Ma da quando i primi effetti macroscopici dei cambiamenti climatici sono davanti agli occhi di tutti – gli abitanti di altri Paesi, in Africa e negli atolli del Pacifico, ne avevano dovuto prendere atto ben prima – nella psiche di governanti e governati si è insinuata una forma acuta di schizofrenia: si lanciano allarmi, si sottoscrivono impegni come quelli presi ai vertici di Parigi e di Glasgow, si varano piani faraonici: “Next generation EU”, tradotto in italiano in PNRR (190 miliardi) è nato come piano per salvare la prossima generazione (e quelle seguenti) dalla crisi climatica e ambientale.
E cosa ne hanno fatto? Alta velocità, autostrade, porti e dighe, case della salute senza né medici né infermieri (ma con molto cemento) e adesso anche il ponte sullo Stretto e altre “amenità” del genere, cioè disgrazie. Poi si è aggiunta la guerra in Ucraina, in Europa e altrove; forse in tutto il mondo. Ma per ora, come dice il papa, solo “a pezzi”. E con essa, la produzione di sempre più armi. A nessuno viene da chiedere che cosa quelle scelte, quelle produzioni, quei progetti hanno a che fare con la lotta ormai disperata e disperante per arrestare l’incombente catastrofe ambientale. Così, più si consolida la convinzione generale e generica che siamo alla vigilia di una apocalisse climatica, più si va affermando una sorta di negazionismo di fatto, che chiude gli occhi di fronte a una realtà ormai evidente e sospinge a comportarsi come se tutto dovesse continuare come prima.
I principali “negazionisti di fatto” sono i sostenitori (sia decisori che pubblico plaudente) del continuo rifornimento di armi all’Ucraina per mandare avanti quella guerra; senza porsi alcun concreto obiettivo se non la “vittoria” (ma di chi? E su chi?), purché continui la distruzione, da entrambe le parti, di vite, di edifici, di suolo, di acque, fino a fare di quel territorio quel deserto che Chernobyl non era riuscito a portare a termine. È ovvio che bombe, proiettili, razzi, cannoni, carri armati e aerei, sia usandoli che producendone di nuovi e di più, non fanno che accelerare i tempi della crisi climatica e ambientale. Eppure, tra i fautori di quella guerra a oltranza trovate molti ambientalisti nemici della caccia, sostenitori della raccolta differenziata e della salvaguardia delle balene, convinti che occorra fare subito “qualsiasi cosa” (sì, ma che cosa?) per ridurre le emissioni di gas climalteranti.
Ora al centro dell’attenzione c’è l’acqua: il Po è in secca, l’Adige anche e gran parte del resto del mondo pure. Nel PNRR non se ne parlava quasi; adesso si corre (anzi si dice che bisogna correre) a costruire desalinatori per produrre e dighe e invasi per salvare l’acqua che manca. Ma non piove e non nevica e quando c’è la pioggia arriva con tale furore che è impossibile trattenerla, assorbirla e stoccarla; mentre dissalare l’acqua di mare richiede molta energia. Chi la produrrà? Il sole e il vento o il gas e il carbone? Altro capitolo aperto.
Nessuno però dice che l’acqua che c’è si può risparmiare, intanto rifacendo canali e tubature che ne perdono il 40 per cento: se ne parla da trent’anni, ma anche il PNRR non prevede gran che in proposito. Poi recuperando negli abitati l’acqua piovana con canalizzazioni separate da quelle di fogna. Poi con un’agricoltura diversa e una riduzione degli allevamenti intensivi (consumano il 70 per cento di quel 70 per cento di tutta l’acqua disponibile che viene inghiottita da un’agricoltura industrializzata). Poi imparando a usarla meglio nella vita quotidiana. Poi… poi adoperandosi per non essere più negazionisti di fatto.
Ma i fiumi sono in secca perché ad alimentarli non ci sono più i ghiacciai. Anche in montagna non nevica, fa caldo e i ghiacciai scompaiono. A valle l’agricoltura dovrà imparare a usare meno acqua. A monte sciatori e operatori turistici dovranno imparare a fare a meno della neve. Che problema c’è? Si fa la neve artificiale. E giù a moltiplicare gli impianti, le piste, i laghetti (in concorrenza con quelli che dovrebbero far rivivere i fiumi in secca), i cannoni sparaneve. Ma sopra zero gradi neanche la neve artificiale si forma. La fanno solo in Arabia Saudita, per creare una pista nel deserto dentro un tunnel. Tra qualche anno lo sci si potrà fare solo lì. O a Pragelato (Piemonte), dove si progetta di fare un tunnel. Non sarebbe meglio imparare fin da ora a vivere in modo diverso quel che resta delle montagne?
E l’energia? Dovrebbe essere tutta rinnovabile entro il 2050, ma i nuovi impianti procedono a rilento. Intanto, sospinto dalla guerra alla Russia che lo forniva a prezzi d’affezione, va a pieno ritmo il gas. Anzi, l’Italia diventerà, ben oltre il suo bisogno (in realtà già lo è), un ”hub” del gas per tutta l’Europa. Sospinta dalla lobby del gas (in Italia, leggi Eni, il vero padrone del Paese, che passa indenne da un governo all’altro), l’Unione Europea ha deciso che il gas è una fonte energetica di transizione (ma a che cosa?). Quando gli impianti (tubi, rigassificatori e flotte gasiere) in progetto saranno pronti la crisi climatica avrà ormai superato la soglia dell’irreversibilità e quegli impianti saranno da buttare e con loro, anche la vita “agiata” a cui siamo abituati.
Ma anche in questo caso l’unica fonte energetica a cui non si pensa e non si provvede – se non con misure sporadiche e casuali quanto costose, come il “110 per cento” – è il risparmio, cioè l’efficienza in tutti i campi, che potrebbe ridurre anche del 40 per cento gli attuali fabbisogni. Invece, dietro al gas occhieggia il nucleare (anch’esso riammesso dall’Unione come fonte di transizione) che piace a Salvini perché è costoso, inutile e pericoloso come e più del Ponte sullo Stretto. Ma non se ne può fare a meno, perché di energia elettrica avremo sempre più bisogno per alimentare una flotta di 35 milioni di automobili da riconvertire all’elettrico!
Qui si apre un nuovo capitolo. Tutti (dalla Fiom a Salvini) a deplorare il fatto che l’auto elettrica contiene meno pezzi e richiede meno manodopera di quella a combustione. Nessuno a ricordare che persino l’Unione Europea ha stabilito che entro il 2050 il parco veicoli dovrà diminuire del 60 per cento. Dunque, se si rispettasse questo obiettivo a cui nessuno crede (e meno che mai i burocrati che l’hanno introdotto) la riduzione dell’occupazione nel settore dovrebbe andare ben oltre quella connessa al passaggio all’elettrico. E lo farà comunque perché la crisi climatica costringerà un numero crescente di persone ad andare a piedi (o a non spostarsi più) perché nel frattempo non saranno stati varati sistemi di trasporto pubblico o condiviso alternativi all’auto privata, elettrica o no.
D’altronde – qui hanno ragione Salvini e il branco di giornali di destra che gli fanno eco – l’auto elettrica presenta ben pochi vantaggi rispetto a quelle attuali. Consuma di meno, ma produce la stessa quantità di CO2 se l’elettricità continuerà a venir prodotta, in tutto o in parte, con i fossili; ma produce quasi la stessa quantità di inquinamento (particolato), che per l’80 per cento è generato non dagli scappamenti ma dall’attrito dei pneumatici e dei freni (e continuamente risollevato dal rotolamento delle ruote). Soprattutto ingombra quanto l’auto tradizionale, trasformando vie e piazze in parcheggi e camere a gas, devastando la socialità di strada, la vita dei bambini e degli anziani (ma anche quella degli adulti) e allontanando per sempre l’obiettivo, questo sì ecologista, della città dei 15 minuti.
Eppure l’auto elettrica, simbolo della continuità del nostro stile di vita prima e dopo la “transizione energetica” continua a essere al centro delle preoccupazione degli ecologisti: la cartina al tornasole del fatto che non hanno né capito né accettato l’idea della conversione ecologica. Sono e restano dei negazionisti di fatto. Inutile dire che un discorso analogo vale per tutti i natanti da diporto (dagli yacht di superlusso ai barchini fuoribordo, crociere comprese), nonché per tutti gli aerei privati, vero accaparramento del cielo da parte dei superricchi. Ma è il trasporto in generale, sia di merci che di passeggeri, come ha fatto notare Federico Butera a proposito del Ponte sullo Stretto, che è destinato a subire un drastico ridimensionamento: sia che si proceda in questa direzione con il progressivo potenziamento dell’economia circolare, che renderà esuberante gran parte della rete stradale, sia, com’è probabile, che ci si arrivi nel caos, per le rottura delle catene di fornitura indotte dalla crisi climatica e da tutto il disordine ”geopolitico” (leggi guerre) che ne conseguirà.
Anche sugli edifici sarebbe possibile promuovere, con l’efficienza, un risparmio energetico sostanziale, a patto che accanto agli obiettivi fissati per legge dall’Unione Europea (quelli contro cui urla la Lega di Salvini, tacciandola di essere una “patrimoniale” – non sia mai! – sulla casa) si varino a livello locale dei piani che non affidino al caso, come ha fatto il “110 per cento”, la messa a norma di qualche edificio, ma mettano invece in grado ogni proprietario, ogni condominio, ogni struttura, di disporre di un progetto organico che ne affronti tutti gli aspetti, dall’isolamento di pareti e infissi alla fornitura attraverso la costituzione di comunità energetiche, dall’efficientamento degli impianti alle regole di condotta e al finanziamento, ecc. Non succederà.
Ma che senso ha, avrebbe, promuovere la conversione energetica in un Paese solo, quando il resto del mondo (e soprattutto le economie emergenti, che ne rivendicano il diritto, perché non è a causa loro che si è arrivati a questo punto) continuerà a produrre imperterrito gas di serra e devastazioni ambientali che incidono su tutto il pianeta, noi compresi, portandolo allo stremo? Ha senso, posto che ci sia una possibilità di sopravvivere anche nelle condizioni estreme in cui ci si verrà a trovare. Perché le misure di mitigazione delle cause di alterazione del clima che il negazionismo di fatto evita accuratamente di adottare, e anche solo di volere, sono anche tutte misure di adattamento alle condizioni ostiche del “nostro comune futuro”.
Piccolo è bello: produzione e consumo di materiali, di suolo e di acqua, sprechi e produzione di scarti e rifiuti dovranno comunque ridursi drasticamente; i trasporti di merci saranno meno voluminosi e frequenti; i viaggi più impegnativi e sensati; gli impianti di generazione elettrica più differenziati e più distribuiti sul territorio; le città più compatte e gli spazi pubblici più liberi; la solidarietà più necessaria per affrontare le difficoltà di ogni giorno. Chi (le città e i territori) si sarà attrezzato per tempo per queste cose avrà più possibilità di sostenere una vita decente e di accogliere anche le persone costrette a fuggire dal loro Paese reso invivibile forse per sempre.
(fonte: Comune-info, articolo di Guido Viale 25/03/2023)
********************
Il cambiamento climatico che ci riguarda tutti:
serve la rivoluzione verde. Ma le lobby «frenano»
L’allarme lanciato dall Ippc, agenzia dell’Onu: «La temperatura media della terra è già aumentata di 1,1 gradi». Gli interventi di Usa ed Europa

Siamo in ritardo. Tutti: governi, grandi e piccole imprese, pubbliche e private. L’ultimo rapporto pubblicato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ippc), l’agenzia dell’Onu per lo studio dei cambiamenti climatici, è molto netto: la temperatura media della terra è già aumentata di 1,1 gradi. A questo punto c’è il 50% di probabilità di non riuscire a contenere il riscaldamento entro la soglia cruciale di 1,5 gradi, da qui al 2050. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto di anticipare la scadenza al 2040. Come dire: dobbiamo accelerare e dobbiamo farlo ora. Difficile immaginare come si muoverà la Cina, uno dei Paesi più inquinanti del mondo. Nel blocco occidentale, invece, l’Amministrazione Biden e le cancellerie europee stanno cercando di dare sostanza agli impegni e alle dichiarazioni di principio. Tra mille difficoltà. Intendiamoci: sia Washington che Bruxelles hanno messo in campo potenzialmente provvedimenti di grande impatto. Gli americani si preparano a investire circa 369 miliardi di dollari, spalmati in dieci anni, per finanziare la «transizione ecologica» dell’economia. Il nerbo della manovra è formato da circa 69 miliardi da destinare alle aziende che producono pannelli solari, turbine eoliche, batterie e componenti per i veicoli elettrici.
L’Unione europea ha stanziato 750 miliardi di euro, all’interno del «Next Generation eu», per coprire, tra l’altro, sovvenzioni a fondo perduto e prestiti a società attive nelle rinnovabili. Il problema, però, è che l’intervento pubblico non sembra sufficiente per indurre i settori privati più inquinanti, dagli idrocarburi alla chimica fino ad arrivare all’agroalimentare, a cambiare passo. Due soli esempi. Il neo presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva ha annunciato norme più severe per la protezione della foresta amazzonica. Gli alberi vengono abbattuti per fare posto a pascoli per il bestiame e finché le grandi corporation americane alimenteranno la domanda di carne bovina, sarà difficile fermare il disboscamento.
Anche in Europa l’azione delle lobby intralcia o limita la portata della rivoluzione verde. Basti osservare le pressioni di tedeschi e italiani per ritardare il pensionamento delle auto a benzina. Oppure l’intenso fuoco di sbarramento sulla proposta della Commissione europea per vietare le etichette fuorvianti e certificare che i prodotti immessi sul mercato abbiano davvero un basso impatto ambientale. L’ostruzionismo viene da tanti settori: dai cosmetici ai tessuti, dalla plastica agli elettrodomestici. Ma il richiamo dell’Onu dovrebbe valere per tutti: è arrivato il momento di scelte nette.
(fonte: Corriere della Sera, articolo di Giuseppe Sarcina 27/03/2023)

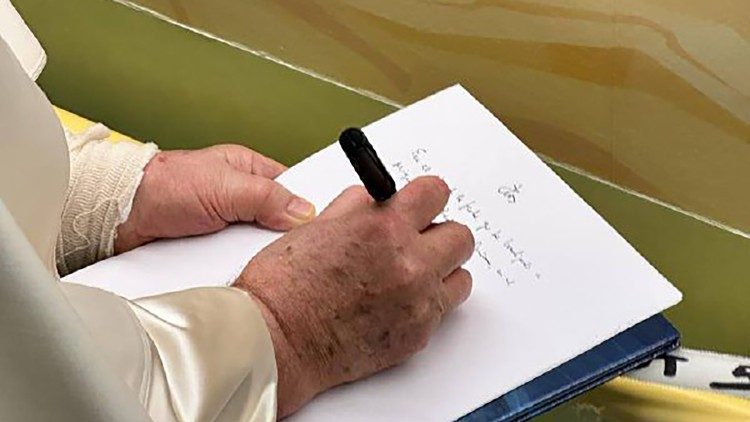
.jpg)















