Un discorso di Natale
CHI ERA GESÙ
di Raniero La Valle
Fuggito a una strage di bambini innocenti come quelli di Gaza, ha dato a ciascuno secondo il suo bisogno ed ha fatto l’esegesi di un Dio senza vendetta, che è solo misericordia, e non sceglie nessun “eletto” contro le altre religioni e gli altri popoli
Riflessione per piattaforma mediatica “Servizio Pubblico” di Michele Santoro da Raniero La Valle
Contro Chi era Gesù? Parliamo oggi di lui perché arriva il suo Natale che è un po’ anche il nostro visto che tutti lo celebrano, senza sapere molto di lui, come fa l’informazione che parla di molte cose senza veramente saperle.
Gesù era di certo una persona straordinaria, altrimenti non si spiegherebbe perché ancora ne parliamo dopo 2000 anni. Di lui è stata raccontata la vita da molti autori, i più importanti dei quali sono stati chiamati evangelisti, Però le loro non sono delle vere biografie, molti avvenimenti non sono stati raccontati come fossero fatti di cronaca, ma piuttosto per il loro significato, per far capire altre cose più importanti, ma in modo che difficilmente si può pensare che veramente siano in tal modo accaduti.
Allora per capire Gesù ricordiamo alcuni di questi fatti, il cui racconto è stato tramandato di padre in figlio, di generazione in generazione. Se ne possono raccontare solo alcuni perché, come dice l’evangelista Giovanni alla fine del suo vangelo, se si volessero raccontare tutte le cose compiute da Gesù, con tutti i loro significati, il mondo intero non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
Gesù era un ebreo di Galilea, nato a Betlemme, la piccola città che come tutti sanno sta vicino a Gerusalemme. E qui c’è il primo racconto incredibile, ma è incredibile per quel tempo di allora, purtroppo non è incredibile per il tempo di oggi, per le cronache di oggi.
Il racconto incredibile è che egli appena nato, sia sfuggito a una strage in cui furono uccisi tutti i bambini di Betlemme e del territorio circostante. E ciò avvenne perché il re del tempo, che si chiamava Erode, pensava che uno di quei bambini, crescendo, avrebbe potuto contendergli il regno, mettere in gioco il suo potere; e allora pensò bene di premunirsi uccidendoli prima, per difendersi da ciò che qualcuno di loro avrebbe potuto fare da grande; e non sapendo chi sarebbe stato, decise di farli uccidere tutti. Ed è proprio quello che in questi giorni è successo a Gaza, dove non uno, non due, non cento, ma 5000 bambini sono stati uccisi fin nelle incubatrici, fin nel ventre delle madri perché se crescevano, chissà, potevano finire con Hamas, e in ogni caso erano palestinesi, e lì non ci devono stare. E quanto ai grandi, se non sono tutti di Hamas, sono abbattuti perché fanno scudo ad Hamas, anche se sono ebrei con la bandiera bianca o sono lì perché funzionari dell’ONU.
Ora, mentre questo oggi è veramente avvenuto, non c’è nessun testo storico che parli di una strage di bambini innocenti nella Palestina di allora; si tratta invece di un racconto midrashico, che è un genere letterario simbolico per dire un’altra cosa; e ciò che voleva dire quel racconto è che la vita di quel bambino nato tra i pastori era così importante, così preziosa, che assolutamente si doveva salvare perché potesse essere poi ragione di bene per gli altri. E anche oggi la vita di ogni bambino è preziosa, anzi, come ha detto la senatrice Liliana Segre, esprimendo il suo dolore per i bambini ebrei e palestinesi uccisi negli eccidi di Gaza, la vita di ogni bambino è sacra.
Per fortuna Gesù fu salvato dal padre e dalla madre che fuggirono in Egitto, ma anche questo non sarebbe possibile oggi, perché è vero che tutti sono obbligati a fuggire da Gaza, però trovano le frontiere chiuse e l’Egitto non li fa entrare.
Poi c’è un altro episodio che si può raccontare, ed è la prima uscita pubblica di Gesù riferita da Giovanni, anzi non era tanto pubblica quanto privata, perché si trattava di un pranzo di nozze a cui Gesù e sua madre erano stati invitati per festeggiare gli sposi. Ora, che cosa c’è di più importante in un pranzo di nozze se non il vino? Qualcuno può dire che è più importante il vestito della sposa, o i discorsi che si fanno per gli auguri, o i brindisi. Ma senza vino è la festa che se ne va, e se finisce perché era troppo poco gli sposi si mortificano e invece di gioire si rattristano. Gesù se ne accorge, perché glielo dice la madre, e che fa? Non fa una predica per dire che ci sono cose più importanti del vino, dell’allegria, e che bisogna accettare le contrarietà e i dolori, no, fa una cosa più semplice e più piena di amore, cambia l’acqua in vino, e anzi per non far fare agli sposi una brutta figura, sceglie il vino più buono. Che vero miracolo! Anche questo non sappiamo se sia veramente avvenuto, ma perbacco quale lezione! Se vuoi bene a qualcuno, non devi fare quello che tu decidi essere il suo bene, ma devi fare il bene che vuole lui, fare ciò di cui in quel momento ha bisogno lui, e se è il vino gli dai il vino, se ha sete gli dai l’acqua, se ha fame gli dai il pane, e magari in forza del tuo amore riesci perfino a moltiplicare i pani, e perfino i pesci, e se è nudo lo vesti, e se è malato e lasciato solo a morire lo vai a visitare e lo conforti, e se ha camminato e fatto male ai piedi gli lavi i piedi, e se è imprigionato cerchi di liberarlo e non gli dai il 41 bis, e se è preso come vittima, offerto in sacrificio mandato a morire ti fai mettere in croce al posto suo, per affermare che nessuno deve essere ucciso dal Pilato di turno, che il tempo dei sacrifici, dei capri espiatori, della vendetta, della guerra, è finito, allora e per sempre.
E poi c’è un altro episodio, un altro evento. Ma questo non è simbolico, di certo è avvenuto davvero, perché se anche Gesù avesse fatto solo questo, avrebbe fatto la cosa più importante della sua vita, proprio ciò per cui era venuto. Di che si tratta?
Siccome Gesù era ebreo, frequentava la Sinagoga ed era usanza che qualcuno dell’assemblea prendesse il rotolo della Scrittura, cioè quello che allora era il libro della Legge e dei Profeti, e ne leggesse per tutti i fedeli una pagina.
Gesù dunque entra nella Sinagoga di Nazaret e siccome era un maschio adulto, gli danno da leggere il libro. E lui svolge il rotolo, e arriva fino al cap. 61 del Profeta Isaia. E che cosa c’era scritto in quel punto?
Dice il profeta Isaia:
Isaia, 61
1 Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
2 a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vendetta del nostro Dio,
E che cosa legge Gesù?
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
19 a proclamare l’anno di grazia del Signore .
E a quel punto si ferma, riavvolge il rotolo e lo riconsegna a chi glielo aveva dato. E perché non ha letto l’ultima riga? Dove è finita la vendetta di Dio? Dove sta il giorno della vendetta?
La vendetta non c’è più. Il Dio che annuncia Gesù, quello stesso Dio di Israele che era invocato nella Sinagoga è un Dio che è solo misericordia, non è più un Dio che punisce, che si vendica, non è un Dio buono con i buoni e cattivo con i cattivi, che dà il bene per il bene e il male per il male. È un Dio, che arriva prima, che “primerea” come dice papa Francesco, prima ancora che gli uomini lo cerchino.
Ma con quale autorità Gesù dice una cosa così sconvolgente, che cambia il modo in cui gli Ebrei si rappresentavano Dio, anzi la concezione che ne avevano tutti i popoli giunti alla fede monoteistica? È la stessa domanda che gli fanno i suoi compaesani di Nazaret. Con che autorità tu fai questo? Non sei il figlio del falegname? E perché tutto restasse com’era, già allora cercano di uccidere Gesù, di gettarlo dalla rupe.
Sì, è il figlio del falegname, è un uomo come gli altri, ma come poi diranno i suoi discepoli e la sua Chiesa, Dio stesso gli ha dato l’autorità, anzi il compito di rivelare il suo vero volto, il vero rapporto di Dio con gli uomini, di farne l’esegesi, cioè di interpretarlo correttamente. Questo dice l’evangelista Giovanni, che lo riconosce come figlio dell’uomo e insieme figlio di Dio, incarnazione di lui. E proprio questa è la buona notizia che Gesù dà ai suoi fratelli ebrei e a tutti gli uomini: Dio è per tutti, non si mette alla testa di un esercito contro un altro esercito, di un popolo contro altri popoli, perché ama tutti, e vuole che tutti siano salvi. Certo è una rivoluzione della fede, della teologia, delle stesse pagine meno ispirate della Bibbia, e invece, proprio come dice la Bibbia, è un Dio che ama gli uomini e perfino gli animali, e si pente del male che secondo i falsi profeti avrebbe promesso di fare, e non lo fa.
Però quella immagine del Dio tremendo e affascinante, assolutamente altro e assolutamente altrove, onnipotente e spietato, è dura a morire, e neanche Gesù ce la fa a cambiarla, e per questo ci rimette la vita, e finisce sulla croce. Ma l’umanità si porterà dietro per secoli quell’immagine travisata di Dio, e canterà il Dies Irae, scriverà la Divina Commedia, dipingerà il Giudizio Universale con i condannati a testa in giù, e dirà che l’inferno non è quello che facciamo noi sulla terra, ma quello che Dio avrebbe allestito nei cieli, al di là della terra, legittimando la violenza e perfino lo sterminio, la vendetta, e la rappresaglia, fino al cento per uno. È rimasto nella cultura comune un Dio impietoso, che se fosse senza misericordia, non sarebbe nemmeno un Dio, come dice papa Francesco. Ed è per questo che i bigotti, i primatisti, i guerrafondai non lo possono vedere e ce l’hanno con lui.
Ma alla fine quel Dio è morto. È morto nei campi di sterminio, è morto a Hiroshima, è morto nei barconi dei migranti: troppo grande è la violenza umana perchè sia verosimile quella divina. E infatti Hans Jonas, un grande filosofo ebreo, ha scritto che è cambiato il concetto di Dio dopo Auschwitz, e un altro nel lager nazista ha detto che Dio non era tra i potenti, ma era appeso alla forca anche lui con quel ragazzo ebreo impiccato dagli aguzzini, e un grande cristiano, Dietrich
Bonhoeffer, dirà che Dio non è un tappabuchi delle debolezze umane, e papa Giovanni dirà che la guerra è fuori della ragione umana, figuriamoci di quella di Dio.
Perciò finalmente possiamo credere che se Dio esiste, non è quello di chi dice, uccidendo, “Dio è con noi”, ma è il Dio di Gesù che è il Dio della pace.
Per cui la domanda oggi non è più: “quale concetto di Dio dopo Auschwitz?” ma “quale concetto di Dio durante Gaza?”: e la risposta è che forse è un Dio che ispiri le genti a piangere su Gerusalemme e su Gaza, Hamas a non uccidere Ebrei, Israele a fermarsi sul ciglio dell’abisso, a non trafiggerne mille per uno, noi tutti a rimettere in comunione la Terra e la dignità di tutte le creature.
GUARDA IL VIDEO
(Fonte: Chiesa di Tutti Chiesa dei Poveri)







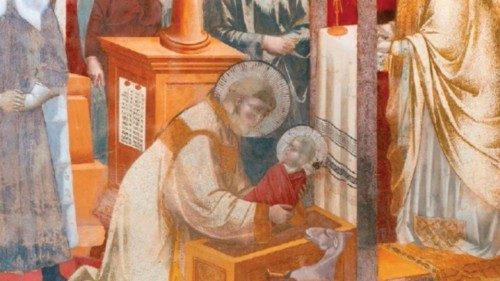






.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
